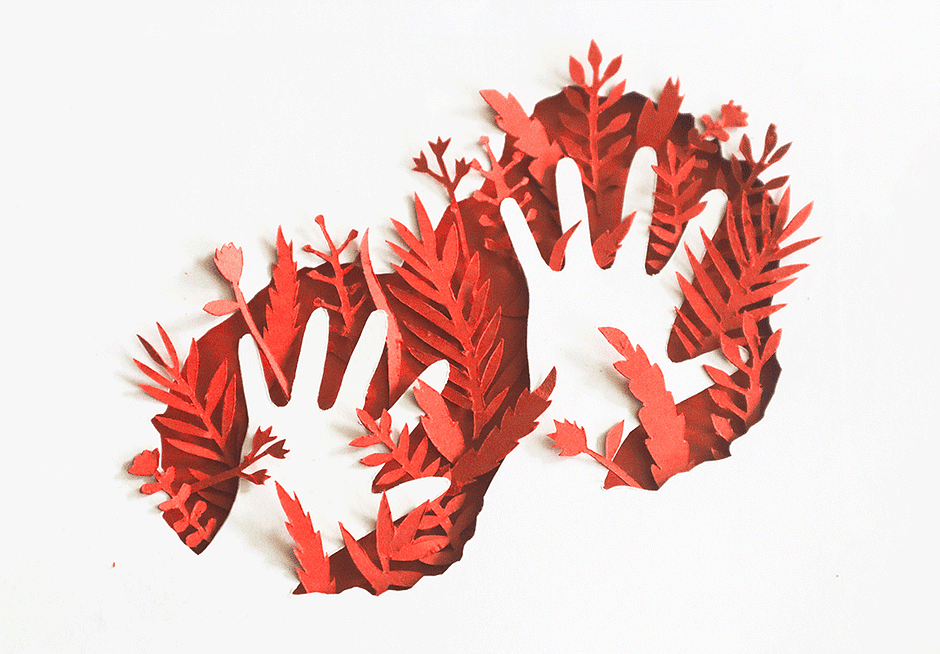Chi protegge le aree protette e perché?

di Stephen Corry
Articolo originale pubblicato sulla rivista del World Rainforest Movement (Bulletin 249, marzo/aprile 2020).
Sembra che tutti si stiano interessando e convincendo sempre più del piano dell’industria della conservazione di raddoppiare la superficie delle aree protette, che dovrebbe arrivare a estendersi su circa il 30% (o addirittura il 50%) del pianeta. Il numero è arbitrario, il punto è che queste aree sono viste come la soluzione a quasi tutti i grandi problemi attuali: la perdita della biodiversità, il cambiamento climatico, e adesso – che ci crediate o meno – anche il COVID-19!
Non sarebbe bello? D’altronde, tutti concordano sul fatto che siano questi i grandi problemi – tutti quelli che non stanno morendo di fame o che non rischiano di essere bombardati o uccisi, intendo… Ma pretendere che le aree protette siano la risposta a tutti questi problemi è davvero una grande menzogna: non ne risolveranno nessuno! Eppure, quando si racconta una bugia bella grossa e si continua a ripeterla, a un certo punto la gente finisce per crederci.
Uno degli aspetti più drammatici del proporre soluzioni false è che si distoglie attenzione da quelle che potrebbero essere le vere soluzioni. Ma purtroppo è anche peggio.
Perdita della biodiversità
Analizziamo uno per uno i tre problemi che le aree protette pretendono di poter risolvere. La perdita di biodiversità dovrebbe essere il più evidente e immediato. In fin dei conti, se si recinta un’ampia superficie di terra e vi si impedisce qualsiasi attività umana, la biodiversità non dovrebbe aumentare rispetto a quella iniziale?
L’idea è gravemente viziata sotto tre aspetti. Innanzitutto, la cosiddetta “wilderness” (una terra vergine e selvaggia) è frutto dell’immaginazione degli Europei. È il mito con cui, per più di 2.000 anni, si è contrapposta la “civilizzazione” alla “wilderness”: terre fuori dal regno (pensate all’Impero romano), popolate da barbari nomadi e ostili. Territori che i Romani cercarono di “domare” principalmente per garantirsi le loro risorse: schiavi, sale, stagno, qualsiasi altra cosa. Oggi diciamo di voler mantenere questi territori “selvaggi”, ma in realtà c’è ancora qualcuno che mira alle loro risorse – per trarre profitto dalle attività rese accessibili proprio dall’istituzione delle aree protette: il turismo, il taglio degli alberi, le piantagioni estensive e persino l’estrazione mineraria.
Ma queste aree non sono “selvagge”. Gli esseri umani hanno continuato a modificare l’ambiente quasi ovunque per tutta la loro esistenza. E perché non farlo? In quanto specie più intelligente sulla Terra, perché non dovremmo alterare flora e fauna a nostro comodo, così come fanno tante altre specie animali?
Gli uomini hanno ripulito la terra con il fuoco, hanno modificato l’equilibrio delle popolazioni animali attraverso la caccia, hanno trasferito piante da un continente all’altro, hanno addomesticato gli animali (il cane è il primo di cui siamo a conoscenza) – e tutto ciò decine di migliaia di anni prima di quella che oggi chiamiamo “agricoltura”. E le alterazioni dell’ambiente circostante sono aumentate quando le coltivazioni agricole e l’allevamento hanno iniziato a prendere il sopravvento su caccia e raccolta (e dimenticatevi della favoletta europea secondo cui l’agricoltura è stata scoperta in Medio Oriente). I pastori hanno creato nuovi pascoli, le loro mandrie hanno progressivamente portato le sementi in aree sempre più estese e hanno aperto nuovi spazi. Gli esseri umani hanno manipolato la flora creando centinaia di nuove colture che non sarebbero potute sopravvivere senza l’intervento umano. Pensiamo ai terrazzamenti sui pendii collinari, agli incendi stagionali, alla caccia selettiva (ad esempio a castori), all’alterazione dei corsi d’acqua…
Studi recenti sottolineano il fatto che le grandi “terre selvagge” della Terra – come l’Amazzonia, le pianure africane, la giungla indiana e così via – non sono altro che opere umane forgiate nel corso di millenni. Ovviamente, i colonizzatori europei non riconobbero questo contributo, e non lo fa nemmeno l‘attuale narrativa della conservazione. Il termine “wilderness” è stato promosso a partire dalle “guerre indiane” statunitensi, quando i Nativi Americani furono buttati fuori dai neonati parchi nazionali: solo un altro capitolo della loro lunga storia di sottomissione e “addomesticamento” da parte dell’Occidente. Il razzismo che all’epoca era al centro della narrativa della conservazione nascente, persiste ancora oggi, sebbene un po’ celato.
Il secondo problema insito nell’idea che le aree protette proteggano la biodiversità, è che non c’è alcuna prova che siano particolarmente utili a tal fine. È impossibile misurarlo con accuratezza (cosa conti esattamente?), ma gli studi dimostrano che le terre gestite dai popoli indigeni sono molto più efficaci: sta finalmente diventando assiomatico che l’80% della biodiversità terrestre si trova nei territori indigeni.
Il terzo problema è che, in realtà, le aree protette possono addirittura portare alla perdita di biodiversità! Sfrattando i popoli indigeni (e scordatevi che le espulsioni sarebbero storia passata perché è una menzogna!) si impedisce a coloro che hanno dimostrato di saper proteggere la biodiversità di continuare a fare ciò che per lungo tempo hanno fatto molto bene; li si getta nella spazzatura a gravi spese dell’ambiente.
Se siamo sinceri nel voler frenare la perdita di biodiversità, allora, il metodo più veloce, economico e ben collaudato sarebbe quello di sostenere quanta più terra indigena possibile, e di restituire ai popoli indigeni il controllo di quel che gli è stato sottratto, ovunque praticabile.
Cambiamenti climatici
L’idea secondo cui le aree protette contribuirebbero a risolvere la crisi climatica è facile da scardinare, al punto che c’è da chiedersi come qualcuno possa avere maturato un’idea tanto ridicola. Per dirla in breve, se il mondo produce la stessa quantità di inquinamento attuale, ma solo dal 10% dalla sua superficie (o anche dal 5%), che differenza fa quel che accade nel 30% “protetto” (o in qualsiasi altra percentuale)? L’impatto sul clima rimane esattamente lo stesso. La logica è stringente: si può recintare un pezzo di terra, ma non il vento.
Se una delle principali cause dei cambiamenti climatici è l’uso dei combustibili fossili, allora la soluzione è altrettanto semplice: bisogna bruciarne di meno e dimenticarsi di false soluzioni come le “compensazioni” o le “zero emissioni nette”. È un’illusione pensare che questo possa accadere senza diminuire i consumi nei paesi ricchi, che utilizzano notevolmente più energia rispetto ai paesi poveri: qualsiasi cosa accada, bisogna eliminare queste disuguaglianze immense e crescenti, per il bene di tutti.
Un maggior numero di aree protette non aiuterà a combattere il cambiamento climatico.
COVID-19
L’idea che un numero maggiore di aree protette prevenga o riduca l’eventualità di pandemie è nuova ed è un palese tentativo di sfruttare la crisi attuale per promuovere il programma della cosiddetta “conservazione-fortezza”, che non ha alcun tipo di connessione con la pandemia. Non è altro che una cinica manovra di marketing.
I coronavirus furono scoperti per la prima volta dagli scienziati decine di anni fa. Come ormai tutti sappiamo, prima di passare all’uomo il COVID-19 (dall’inglese COronaVIrus Disease del 2019) si è sviluppato in una specie animale non-umana. Non sappiamo ancora quale: forse i pipistrelli selvatici o forse un altro animale. Potrebbe esserci stato un ospite intermedio, come i pangolini – facilmente reperibili in Cina, dove vengono anche allevati – ma non sappiamo nemmeno questo. E non sorprende: il batterio portatore della peste, della drammatica “morte nera” che fece fino a 75-200 milioni di morti, è noto, ma la sua trasmissione, che si riteneva avvenire tramite le pulci dei ratti, potrebbe essere in realtà dovuta a contatti “uomo-uomo”. L’idea che il COVID-19 abbia le sue origini nel commercio di specie selvatiche non è accertata, ed è probabilmente priva di senso.
Ad ogni modo, l’umanità ha da sempre sofferto di malattie zoonotiche. Abbiamo sempre vissuto a stretto contatto con gli animali. L’influenza, che accelera o causa la morte di forse 290.000-650.000 persone l’anno, ci è stata trasmessa da un uccello della giungla tramite i suoi discendenti addomesticati come polli e anatre. Il morbillo, che uccide circa 140.000 persone l’anno, proveniva originariamente da bovini addomesticati. (Alla data di questo articolo, i morti per COVID-19 si pensa siano circa 850.000).
Esistono milioni di tipi di virus e sono ovunque, anche dentro di noi, mutano e probabilmente sono in circolazione sin dalle prime cellule viventi. Fanno parte del tessuto della vita.
Un numero maggiore di aree protette non aiuterà a prevenire le pandemie. Semmai avrà l’effetto opposto! Sfrattando i popoli dalle loro terre, accrescerà infatti il sovraffollamento delle baraccopoli urbane, dove sono già concentrati un quarto degli abitanti delle città del mondo.
Che tipo di area protetta può aiutare a fronteggiare questi tre problemi?
Le aree protette, così come sono intese oggi, non possono risolvere nessuno di questi problemi, e anzi potrebbero addirittura aggravarli. Ma si potrebbero facilmente immaginare aree protette in grado di aiutare a proteggere la biodiversità: basterebbe che proteggessero i diritti territoriali dei popoli indigeni! Il problema è che, a parte qualche irrilevante promessa di facciata, non vi è alcun indizio che chi sostiene le aree protette voglia farlo.
Oggi esistono due tipi di aree protette. Vi sono quelle in cui abitano popolazioni locali piuttosto numerose e politicamente forti: in quelle zone, non si potrebbe creare nessuna area protetta senza soddisfare le esigenze dei locali. Nel Regno Unito, ad esempio, nei parchi nazionali vi sono fattorie attive e persino villaggi e città; vi si può entrare e uscire senza restrizioni, e la gente non viene espulsa perché ha un notevole peso politico. Il secondo tipo di area protetta – la cosiddetta conservazione-fortezza – è invece comune in Africa e alcune regioni dell’Asia, e ripropone il modello dei primi parchi nazionali statunitensi. La popolazione locale, quasi sempre indigena, viene sfrattata con la forza, la coercizione o la corruzione: i migliori custodi della terra, un tempo autosufficienti e con una impronta ecologica più bassa di chiunque di noi, vengono diseredati e impoveriti, e spesso finiscono per aggiungersi alle fila del sovraffollamento urbano.
Non c’è alcun motivo di pensare che il nuovo invito a raddoppiare il numero delle aree protette significhi qualcosa di diverso. Chi promuove queste aree parla ancora in gran parte di “terre selvagge” o di “wilderness” per riferirsi alle terre in Africa o Asia dove vivono i popoli indigeni, dove la conservazione-fortezza è viva e ben consolidata, e dove ancora oggi, proprio mentre scriviamo, le persone vengono cacciate dalle loro terre (ad esempio nel Bacino del Congo o nelle riserve della tigre in India).
Chi vuole le aree protette e perché?
Le aree protette sono energicamente promosse da organizzazioni per la conservazione, da governi e multinazionali. Le ONG mirano ad ottenere quanto più denaro possibile per mantenere il loro dominio su una superficie del mondo sempre maggiore, che considerano minacciata dagli abitanti locali. I governi detestano i popoli autosufficienti, difficili da tassare e controllare, e che tendono a guardare con scetticismo ai tentativi dello Stato di scavalcare la comunità. Le grandi aziende mirano ad aumentare i loro consumatori e a estrarre nuove materie prime, spesso dalle aree di “wilderness"; hanno anche bisogno di luoghi in cui poter dichiarare di “compensare” il carbonio che emettono, per ripulire quanto più possibile la loro immagine e la reputazione.
Il risultato è che miliardi di dollari dei contribuenti vengono incanalati in aree per la conservazione dove non viene fatto nessun controllo sulla tutela dei diritti umani, regolarmente violati. La maggior parte di questi progetti sono concepiti da ONG, da società private a scopo di lucro oppure da entrambi – in partnership con aziende estrattive o per il taglio del legno, la caccia ai trofei, le concessioni turistiche e l’agribusiness. Si prendono la terra che per molto tempo ha sostenuto gli stili di vita locali, e la rimodellano per il profitto di pochi stranieri. In alcune aree, ad esempio, c’è una evidente sovrapposizione tra concessioni minerarie e aree protette. Le ONG per la conservazione sono, almeno in parte, controllate da manager aziendali che siedono nei loro Consigli, con cui collaborano e che le finanziano, perché dunque aspettarsi qualcosa di diverso?
L’idea della conservazione-fortezza – aree protette che salvaguardano la terra dalla sfrenata avidità dei locali – è un mito coloniale: è una favoletta dannosa per l’ambiente, radicata in ideologie o peggio. Sono molti gli ambientalisti che ora ne sono a conoscenza, ma tacciono nel timore di ripercussioni lavorative o di azioni legali.
Privando le popolazioni rurali dei loro stili di vita ampiamente autosufficienti (caccia, pastorizia, raccolta e coltivazione del proprio cibo e delle piante medicine) e costringendole a entrare al livello più basso dell’economia monetaria, molte aree protette causeranno ulteriore perdita di biodiversità, aggraveranno gli impatti dei cambiamenti climatici e aumenteranno la probabilità di pandemie: esattamente il contrario di quanto si propongono! Se i sostenitori della conservazione-fortezza dovessero vincere la loro battaglia, gli effetti saranno ulteriore impoverimento e fame per milioni di persone. È difficile che le comunità locali possano tollerarlo e in alcuni casi cercheranno semplicemente di riappropriarsi delle loro terre con la forza segnando così, per sempre, la fine di quelle aree protette.
Non voglio dire che molti sostenitori della conservazione-fortezza e delle aree protette non credano alla loro grande menzogna, al contrario, ne sono convinti! Vi si aggrappano ciecamente come fosse “un articolo di fede”. Alla fine, sarà un disastro anche per loro perché il loro lavoro si rivelerà controproducente. Ma la tragedia causata lungo la strada – alle persone e alla natura – è molto più grave. Se ci preoccupiamo della biodiversità e dei cambiamenti climatici, non possiamo permettergli di avere il sopravvento. La biodiversità dipende dalla diversità umana: questo è il concetto chiave che deve essere racchiuso al più presto in un’ideologia di conservazione che si batta per il futuro, per il nostro pianeta e per tutta l’umanità.
Traduzione di Giorgia Volpe
Nota:
- Survival ha lanciato una campagna per fermare la Grande bugia verde.
- Oltre 230 associazioni ed esperti del settore hanno già sottoscritto la dichiarazione delle ONG sul Quadro Globale per la Biodiversità.
- Per comunicare eventuali adesioni, scrivete a [email protected].
- Qui potete partecipare all’azione urgente come singoli.
- E qui sapere di più sulla conservazione colonialista.